 Scendere in una catacomba. Un gesto un po’ inattuale. Generalmente dettato da obblighi scolastici o di studio, raramente da spontanea curiosità. Ieri sono scesa con uno spirito svagato da “turista spirituale” nelle catacombe di Priscilla, sulla via Salaria, approfittando dei bonus offerti dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra in occasione della 5a Giornata delle Catacombe.
Scendere in una catacomba. Un gesto un po’ inattuale. Generalmente dettato da obblighi scolastici o di studio, raramente da spontanea curiosità. Ieri sono scesa con uno spirito svagato da “turista spirituale” nelle catacombe di Priscilla, sulla via Salaria, approfittando dei bonus offerti dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra in occasione della 5a Giornata delle Catacombe.
Scendere, per l’appunto. Un’azione poco praticata, ai giorni nostri. Si scende al massimo in cantina o in garage. Quasi mai dal proprio piedistallo, dalle proprie ambizioni. Quasi mai sulle proprie ginocchia. E anche per onorare i morti, non si è tenuti a inabissarsi in cavità sbancate nella terra o in cunicoli claustrofobici come il cuore delle piramidi o il ventre di cimiteri sotterranei, ma ci si inchina generalmente di fronte a una lapide in un camposanto en plen air.
Secoli e secoli fa non era così. I primi cristiani erano abituati al nascondimento per fuggire alle persecuzioni, ma soprattutto erano poveri: l’architettura negativa (scavare invece di edificare) era decisamente più economica.
Sono scesa dunque, dicevo, in uno dei tanti ventri di Roma scarsamente frequentati e ancor meno conosciuti. Le catacombe è d’obbligo esplorarle in gruppo, anche per ottimizzare l’impegno delle competenti guide. Ma scendere in gruppo in questi luoghi finisce per avere anche un altro significato, forse meno evidente: ci si ricorda che cosa significava procedere in processione, essere parte di una comunità in cammino e in preghiera. E ci si sente anche più al sicuro, avanzando in quella semi-oscurità che inevitabilmente ripropone l’antica, puerile paura del buio.
Scendere nella pancia della città chiassona dentro questi antichissimi cimiteri comporta così una scossa emotiva, brusca quanto garbata: improvvisamente, il silenzio. Improvvisamente il respiro muffoso delle profondità. Improvvisamente la penombra. Improvvisamente pareti umide che si stringono addosso al visitatore in un abbraccio mortifero e insieme suadente. La seduzione del passato, di uno stringente invito alla preghiera. Tutti i sensi sono coinvolti in questo cammino che ha come testimoni solo le eloquenti assenze delle migliaia e migliaia di persone qui un tempo sepolte, e le cui uniche tracce sono i loculi vuoti, le impronte degli spazi occupati dai loro corpi nella pozzolana e nel tufo scavati. Sorta di letti affiancati e sovrapposti, a volte di piccolissime dimensioni (bambini e neonati), a volte magnificati dentro una grande nicchia (qualche raro ricco!), a volte esaltati dentro cubicoli destinati a intere famiglie…
Si cammina così per oltre un chilometro senza stanchezza, senza percepire più le distanze, abbandonando la memoria della linearità di una strada o di una piazza di città, perdendo in parte la concezione del tempo, e dimenticando che sopra le proprie teste il formicolio metropolitano prosegue come al solito, indifferente a questo oceano di pietà che si è potuto concretare nei secoli , rivelando il destino dei cristiani come i veri lombrichi della storia, capaci di modellare le profondità degli spazi fisici ma soprattutto le intimità, fino ad allora inaccessibili o tendenzialmente plagiate, delle coscienze.
Si cammina ora in linea retta, ora curvando, resistendo di volta in volta alla tentazione di avventurarsi nel labirinto dei tanti corridoi laterali fiancheggiati da ambo i lati da altri e altri loculi, nella convinzione che il panorama si riproporrebbe sempre uguale, ma anche nella opposta certezza che ogni loculo ospitò una storia diversa, una scelta, una sfida, forse un martirio.
Un paesaggio sotterraneo che modifica inevitabilmente il paesaggio interiore: un cammino che sembra rivoluzionare la nostra geometria euclidea, dissolvendo la percezione della linea retta e, contemporaneamente, tutti i nostri puntelli, le nostre false certezze e presunzioni. Là sotto tutto è concavo, accogliente, smussato, ospitale e inquietante come l’universo di Einstein dove lo spazio dialoga e si modifica col tempo, dove ciò che è chiuso in realtà apre e promette, dove ciò che è stretto e fermo in realtà richiede la nostra partecipazione, il nostro evolvere, forse il nostro nascere o rinascere.
Si procede così come dentro le viscere della balena di Pinocchio, che solo sul finale si rivelano essere invece ben altro: il grembo di un dio incarnato precisamente dentro la terra, che dal buio di queste viscere terresti è risalito al cielo, capovolgendo il senso della storia. Lo ricordano anche i pochi –eppure tanti-, struggenti affreschi superstiti, uno in particolare: la più antica rappresentazione di Maria col bimbo tra le braccia, affiancata da un profeta che indica in alto una stella. Figure un po’ ingenue e sfocate eppure talmente potenti, dalle insignificanti dimensioni per un promemoria immenso: arriverà una luce che illuminerà ogni angolo dell’universo.
Una certezza che, per noi disincantati visitatori del XXI secolo, si è riproposta sul finale della visita, quando alfine “uscimmo a riveder le stelle”. Accolti nell’abbraccio luminoso della sovrastante basilica di san Silvestro (si accede in un punto e si esce in un altro dove non si pensava minimamente di essere arrivati), si riceve il “premio” di un trittico musicale dovuto al giovane Trasimeno String Trio. Le note di Haendel, Bach e del Panis Angelicus di César Franck hanno siglato un memento importante: solo dopo essere scesi dentro le inquietanti strettoie della materia possiamo conquistare la gioia quasi anarchica e liberatoria dello spirito.
16 ottobre 2022
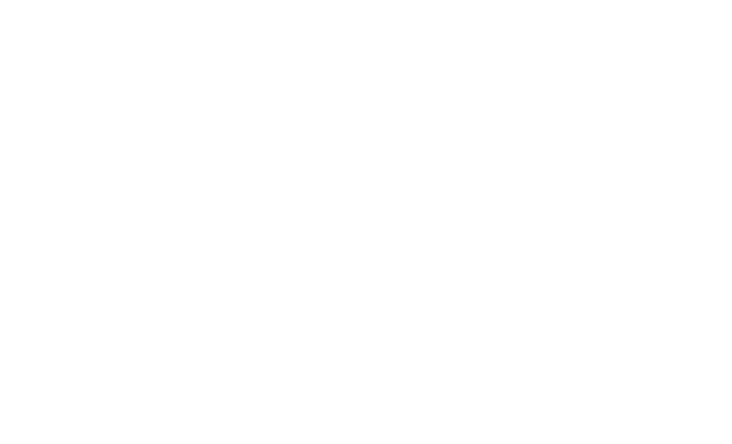
CAROLINA
Splendida meditazione grazie